
Lo scrittore austriaco Joseph Roth deve molta della sua notorietà ad un romanzo in particolare, la Marcia di Radetzky (Radetzkymarch) apparso nel 1932. Un’opera emblematica attraverso la quale l’autore, giunto ormai alla maturità, porta a compimento un realistico e commovente affresco del declino dell’Impero Asburgico, condensando in esso tutta la sua esperienza artistica e le tematiche a lui più care. In questo lavoro l’autore ripercorre, seppure non in senso strettamente storiografico, ma psicologico, la lunga e lenta agonia dell’Impero che aveva avuto inizio nel 1859, con la sconfitta subita dagli Austriaci per opera delle forze franco-piemontesi e che era proseguita attraverso un’infausta sequenza di débacle militari (vedi quella di Sadowa del 1866) fino a giungere con la morte dell’Imperatore Francesco Giuseppe – stella polare e punto di riferimento cosmico dell’Impero – al definitivo tracollo della monarchia (1918) e la conseguente riduzione dell’Austria a rango di nazione di second’ordine: ricettacolo spento di un’antica tradizione, di regalità e valori.

Da sinistra: Joseph Roth e la consorte Friedl e un amico.
La fine dell’Impero Austro-Ungarico significò per Roth, come per altri famosi scrittori austro-tedeschi degli anni Venti/Trenta (Karl Kraus, Herman Broch, Robert Musil e Franz Werfel) qualcosa di ben più grave e traumatico del termine di un periodo storico. Essa rappresentò, infatti, il tramonto di un singolare ideale di vita e di una particolare cultura. Pur criticando le sue strutture ed evidenziando le molteplici contraddizioni socio-politiche ed economiche che ormai da decenni minavano l’impalcatura del grande mosaico etnico-linguistico asburgico, Roth guardò sempre con nostalgia a questa realtà perduta nella quale era cresciuto, rammaricandosi di dovere adattare il suo spirito e la sua indole all’avvento di un’era contrassegnata da una sostanziale carenza di valori spirituali ed eroici. Un’epoca, quella del primo dopoguerra, caratterizzata dall’inarrestabile avanzata di una «modernità» e di una sapienza tecnologica e sociale nuova, percepita dall’autore come inevitabile, ma a lui sgradita, vuoi per suoi intimi convincimenti ideologici, vuoi per le sue stesse origini religiose. Con la fine dell’Impero, egli scrisse, «noi tutti perdemmo un mondo, il nostro mondo».
Friedl Roth.
E a questo proposito va sottolineato che una delle caratteristiche tipiche del pensiero di Roth è da ricercare appunto nel rapporto ambiguo che questo scrittore – Ebreo e proveniente dalle terre orientali dell’Impero – mantenne per quasi tutta la sua esistenza nei confronti della cosiddetta «civilizzazione occidentale» di marca cristiana: un rapporto di odio e amore facile da riscontrare nelle pagine di diverse delle sue opere.
Joseph Roth era nato a Schwabendorf, in Volyhnia, da una famiglia di Ebrei osservanti (suo nonno era un rabbino). Il padre abbandonò la famiglia prima che Joseph nascesse e morì, secondo quanto riporta lo stesso autore, in un manicomio di Amsterdam. Riguardo la fine del genitore, alcuni biografi sostengono trattarsi però di una mistificazione di Roth. Sembra, infatti, che il padre sia scomparso in terra di Russia. Dopo l’abbandono, il piccolo Joseph visse a lungo con i parenti, ma di questo periodo, presumibilmente triste e difficile, ben poco si sa. Anche perché l’autore non ci ha lasciato che pochi accenni. Tra il 1901 e il 1905, Roth frequentò la Baron-Hirsch-Schule, a Brody, e tra il 1905 e il 1913 l’Imperiale Ginnasio del principe Rodolfo. Successivamente, tra il 1914 e il 1916, egli studiò letteratura e filosofia presso le università di Lemberg e di Vienna. Nel 1916, Roth venne arruolato nell’esercito austriaco e prestò servizio in un reggimento fucilieri di stanza sul fronte orientale. E in quell’inferno egli conobbe fino in fondo l’orrore della guerra di trincea, la disperazione e la debolezza degli uomini, e l’incubo della prigionia. Catturato dai Russi, Roth trascorse parecchi mesi in diversi campi di concentramento, osservando e studiando la psicologia umana. Alla fine del conflitto egli fece ritorno in Austria. All’inizio degli anni Venti, Joseph Roth iniziò ad occuparsi di giornalismo, a dire il vero senza eccessiva convinzione. «Un giorno, disperato perché ogni lavoro era del tutto incapace di soddisfarmi, divenni giornalista… a quel tempo… il mio talento letterario non andava al di là di un diario nel quale scrivevo alcuni circostanziati appunti» (da Le città bianche). Poi si sposò con una donna che risultò poi malata di mente. Dopo il tragico epilogo del suo matrimonio (la moglie dovette essere rinchiusa in un manicomio), tra il 1923 ed il 1932 Roth fu corrispondente per il «Frankfurter-Zeitung», ed ebbe modo di viaggiare in largo e in lungo per l’Europa, visitando e rimanendo, tra l’altro, colpito dalle città e dalle bellezze paesaggistiche della Francia Meridionale alle quali dedicò numerosi reportage, raccolti in seguito ne Le città bianche. Altri suoi approfonditi resoconti fornirono in seguito la traccia per la stesura del noto Ebrei Erranti (Juden auf Wanderschaft) del 1927. Ma Roth aveva esordito come romanziere ben prima delle sue brillanti cronache di viaggio, nel 1923 con il romanzo La tela di ragno (Das Spinnennetz), opera cui aveva fatto seguito l’anno seguente Hotel Savoy. Nel 1926, Roth si recò in Unione Sovietica per indagare circa i risultati della rivoluzione leninista: esperienza che, tuttavia, lo deluse profondamente. Durante il suo soggiorno nell’Est egli registrò a più riprese le sue impressioni in una serie di eccellenti servizi che anch’essi servirono da traccia ad un altro suo significativo lavoro: Il profeta muto (Der stumme Propher) che venne pubblicato dopo molti anni dalla sua morte, nel 1966. Quando Hitler conquistò il potere in Germania, Roth decise di trasferirsi a Vienna. E nell’ex-capitale dell’Impero Asburgico, egli continuò a scrivere sia articoli che racconti, intensificando la sua attitudine all’alcol e alle ore piccole trascorse in piccoli locali e taverne. Tra il 1933 e 1937 Roth visitò e soggiornò in Polonia dove venne invitato per una serie di conferenze. Dopo l’assassinio del cancelliere austriaco Dolfuss e la conseguente annessione del Paese da parte della Germania nazista, Roth si trasferì a Parigi, dove continuò a produrre, ma anche a bere, precipitando in una profonda, ma lucida solitudine. Morì improvvisamente il 27 maggio 1939, all’uscita di un caffè.
Joseph Roth aveva iniziato la sua carriera di scrittore sotto l’influenza del realismo psicologico francese e russo di Balzac, Stendhal, Flaubert, Gogol, Tolstoj e Dostoievscky. In seguito, tuttavia, i suoi lavori si avvicinarono sempre più alla corrente dell’impressionismo viennese di Hofmannstahl e Schnitzler. Dopo l’esperienza di Hotel Savoy e Die Rebellion (entrambi del 1924), ecco l’autore mettere le mani su uno dei suoi più emblematici romanzi: Die Flucht ohne Ende (Fuga senza Fine) (1927), un’opera chiaramente autobiografica nella quale egli rivive le esperienze di un soldato austriaco che, ritornando a casa dopo un lungo periodo di prigionia trascorso in Russia, non riesce più a trovare una sua collocazione sociale e psicologica nel contesto di un mondo completamente cambiato dalla guerra. Qui, il motivo – piuttosto ricorrente nell’opera di Roth – dell’impossibilità a sopravvivere in una società «moderna», frenetica e superficiale che nulla ha ormai in comune con quella precedente, regolata dai principi etici dell’era monarchica e dal lento e naturale scandire del tempo. D’altra parte, tutti i protagonisti dei racconti di Roth degli anni Venti altro non sono che dei «sopravvissuti», dei superstiti scampati ad un immane naufragio nel quale sono spariti valori e certezze ritenuti sempiterni. Dramma intimo, quest’ultimo, che trova la sua eco più profonda ed acuta ne La marcia di Radetzky (Radetzkymarsch). Vero e proprio inno alla nostalgia, traboccante di osservazioni psicologiche e di rimandi culturali; disamina cruda circa l’inutilità di antiche convinzioni, ma pervicace attaccamento ai concetti di onore, lealtà nei confronti della vecchia istituzione imperiale e della sua macchina burocratica e militare intesa come pilastro e giustificazione formale e sostanziale di un potere terreno. Il romanzo trasuda di ineluttabilità frammista a consapevolezza, di gusto pittorico e sensualità edonistica e crepuscolare. Si tratta, in effetti, di un languido, ma virile addio a tutto ciò che è perduto per sempre: un canto intonato da un uomo ormai in disparte, «inabile non soltanto alla vita, ma anche alla morte». Due parole sull’opera. Il libro parte dalle gesta eroiche di un ufficiale dell’esercito austriaco che, durante la battaglia di Solferino del 1859, salva la vita del giovane Imperatore Francesco Giuseppe. Attraverso la memoria dei discendenti dell’eroe, Roth imbastisce una trama che riconduce nella sua essenza narrativa e filosofica ad una visione splengleriana della cultura europea in fase di declino, sopraffatta dall’incalzare del progresso (o del regresso) industriale, politico e sociale. Gli eredi dell’«Eroe di Solferino» acquistano lustro e ricevono dall’Imperatore quale ricompensa un titolo nobiliare: premio simbolico e «ideale» che viene trasmesso di generazione in generazione e che porta con sé l’obbligo di salvaguardare la virtù con un’assoluta devozione verso la monarchia. La vita dell’ultimo erede della famiglia Trotta, Carl Joseph, le cui modeste vicende di carriera e d’amore occupano buona parte del romanzo, si svolge parallela a quella del longevo e malato Imperatore. In seguito allo scoppio del Primo Conflitto, Carl – uomo disilluso e depresso – viene inviato sul fronte orientale dove muore senza tanti clamori e ben lontano dall’aura di gloria dell’avo. Il padre, uno zelante e devoto sottoprefetto, precipita in un profondo sconforto determinato sia dalla perdita del figlio che dalla certezza della fine di un ciclo. E dopo aver atteso nel freddo parco di Schönbrunn l’annuncio della morte dell’ormai vecchio e malato Imperatore Francesco Giuseppe, l’uomo, derubato del suo passato e del suo futuro, si lascia morire in un autunno che preannuncia la finale catastrofe della nazione: epilogo tragico che riconduce in sostanza a quell’incapacità di «sopravvivere al dopo» che rimane uno dei temi cari a Roth. Il denso pathos nostalgico nel quale l’autore inzuppa la penna lo ritroviamo poi in altri successivi lavori, primo fra tutti La cripta dei Cappuccini (Die Kapuzinergruf) (1938), la cui trama ripercorre anch’essa le fasi del declino dell’Impero attraverso le vicissitudini di un’intera famiglia. Storicizzando l’intento narrativo e concettuale di Roth si può forse affermare che l’autore utilizza la sua sincera nostalgia nei confronti della regale epoca asburgica quasi a volere esorcizzare il presente con il passato: un presente che, a partire dal 1933, vede in Europa Centrale l’ascesa e il conclamarsi dell’ideologia hitleriana, e in Russia il contestuale consolidamento dell’assolutismo stalinista. In questo senso, l’anelito dello scrittore (che pur essendo Ebreo si dichiara apertamente «conservatore e Cattolico» in quanto non crede affatto all’utopia opprimente e statica del comunismo, ma neanche alla mobilità della società capitalista) sembra rivolgersi senza indugio ad una Tradizione, quella cristiana mitteleuropea, intesa come coacervo di valori aristocratici, atemporali ed eterni che giganteggiano nell’avvilente confronto con la semplice, pedestre, e talvolta ingannevole, contrapposizione politico-ideologica tra Destra e Sinistra, intesa in senso politologico. Concetto, quest’ultimo, che viene ripreso da altri lavori quale, appunto, Destra e Sinistra (Rechts und Links) (1929) e Giobbe, la storia di un uomo semplice (Hiob) del 1930. In quest’ultimo libro, che si rifà chiaramente al suo pregresso culturale e religioso, Roth offre al lettore una chiave interpretativa del presente e delle sue angosce esistenziali attraverso l’esperienza della paziente, ma non rassegnata santità ebraica. Va notato che buona parte delle opere del «Cattolico» Roth contengono sempre frequenti digressioni sulla realtà ebraica mitteleuropea. Negli Ebrei Erranti del 1927, l’autore si sofferma con affetto, ma freddezza indagatrice sulla realtà delle migrazioni dei nuclei semiti dall’Europa Orientale a quella Occidentale nel periodo immediatamente successivo al Primo Conflitto e alla Rivoluzione Russa. Simpatie per la civiltà cattolica a parte, uno dei motivi centrali dell’opera narrativa di Roth è, come si è detto, la tragica vicenda degli Ebrei dell’Europa Centrale, costretti dal crollo della monarchia austro-ungarica ad emigrare verso l’Occidente europeo e gli Stati Uniti. Un’emigrazione in qualche modo forzata che rinnova l’antica diaspora, costringendo questo eterno popolo di esuli, indissolubilmente legati ad un credo religioso e culturale antico ed unico, a fronteggiare la «contaminazione» di una civiltà occidentale che li avvince e respinge al tempo stesso.
Roth presta poi molta attenzione ai concetti di verità, di contraffazione, di santità e di debolezza che caratterizzano la confusa esistenza dell’uomo moderno. Concetti che emergono tra le righe de Il peso falso (Das falsche Gewicht) incentrato sulla vita di un ispettore di pesi e misure e nel celebre, breve (e drammaticamente premonitore) racconto La leggenda del santo bevitore (Die Legende vom heilgen Trinker) del 1939. Nel suo ultimo lavoro, La milleduesima notte (Die Geschichte von der 1002), anch’esso del 1939, Roth esamina invece il tema dell’auto-inganno, cioè dell’obliterazione della verità e, in ultima analisi, della fuga, non tanto da una realtà sgradita, ma da se stessi. E con questo il cerchio narrativo di Roth si chiude, purtroppo definitivamente, lasciando nel lettore il rimpianto di non potere usufruire di una successiva occasione d’incontro con uno dei più importanti autori del Novecento il cui pieno riconoscimento da parte della critica internazionale tardò però a venire. Come d’altra parte è accaduto ad altri grandi maestri capaci di esprimere eterne verità attraverso il filtro di una propria, esclusiva esperienza di vita ed interpretazione concettuale e stilistica dell’essere.
Bibliografia:
Joseph Roth di Rainer-Joachim Siegel (1995)
Joseph Roths Fluch und Ende di Soma Morgenstern (1994)
Joseph Roth di Wolfgang Müller-Funk (1989)
Ambivalence and Irony in the Works of Joseph Roth di C. Mathew (1984)
Joseph Roth und die Tradition, Edizioni D. Bronsen (1975)
Lontano da dove di Claudio Magris (1971)
Joseph Roth: Leben und Werke di H. Linden (1949).

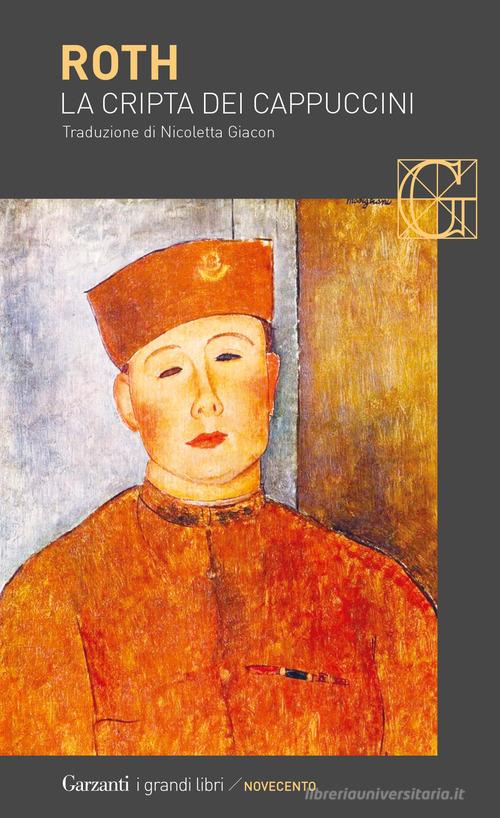
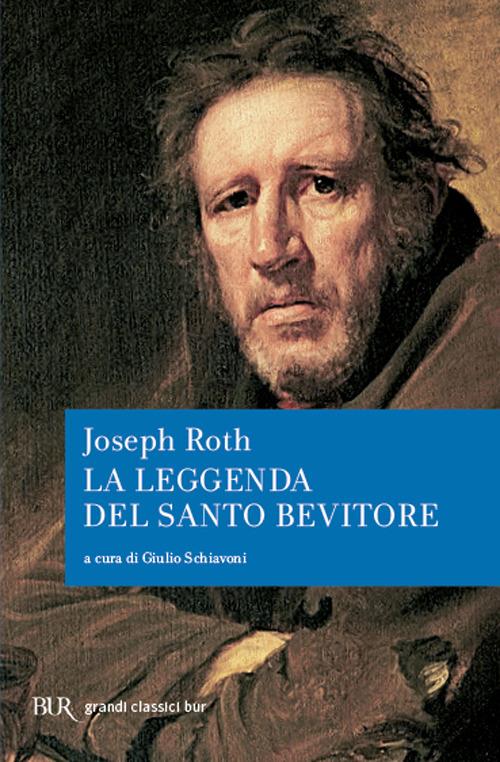

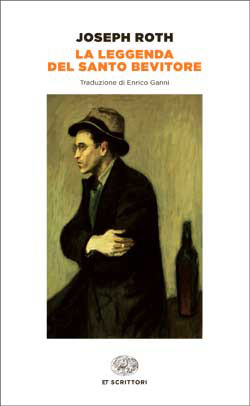

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.