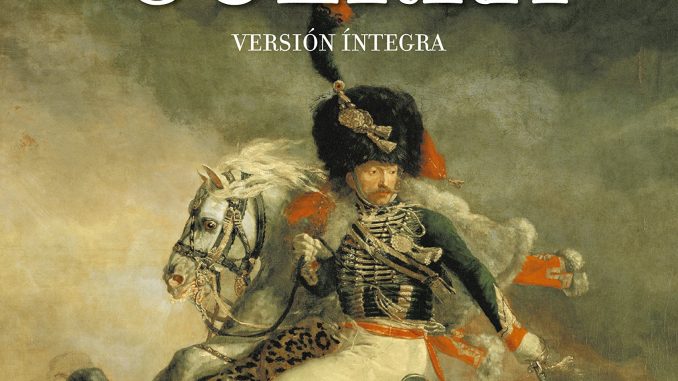
Aspettando la guerra
Nemmeno troppo tempo fa, con semplicismo commovente, la guerra veniva proposta ai giovani come l’effetto di un meccanismo elementare: i ricchi ed i potenti dovevano difendere i propri interessi e, a tale scopo, facevano le guerre. La povera gente veniva, perciò, mandata al massacro, con dei risibili pretesti ideologici: ed essa, supinamente, con lo stesso fatalismo un po’ bovino con cui azionava telai o spingeva aratri, manovrava la terribile macina della battaglia. Alla fine, ricchi e potenti si mettevano sempre d’accordo tra loro, mentre il popolo se ne tornava a casa senza un grazie. Si tratta di una visione piuttosto affascinante della storia dell’umanità: peccato che sia anche piuttosto fantasiosa. Sarebbe bello e tranquillizzante pensare che esistano due umanità distinte: la prima, quella ricca ed egoista, decide a tavolino dove scatenare la prossima apocalisse, per vendere le proprie armi, i propri giornali, le proprie bende, il proprio uranio impoverito. La seconda, che è quella che, evidentemente, raccoglie le simpatie di ogni uomo di buona volontà, si limita a recalcitrare, in varia forma[1], di fronte alla porta del mattatoio e, poi, a versare il proprio sangue innocente e quello dei propri fratelli dell’altra sponda. Questo universo a due piani, penthouse & pavement, è la grande scoperta del pensiero marxista: la lotta di classe che si contrappone alla guerra borghese. Davvero sarebbe la più felice delle spiegazioni: peccato che le cose non funzionino così. Lasciamo perdere l’antichità, quando i poveracci alla guerra non potevano neppure partecipare[2]: le guerre moderne sono state tutte quante affatto peculiari, sia per cause, che per svolgimento, che per esiti. L’idea di paragonare l’esercito professionale inglese della guerra boera con quello semivolontario della guerra civile americana, con le leve di massa francesi e italiane della Grande Guerra, è operazione storicamente assurda. Così come è assurdo pensare che le motivazioni di una guerra coloniale possano essere le medesime di quelle di una rivoluzione armata. E che dire di una guerra borghese che, di fatto, permise al popolo di abbattere proprio dei regimi borghesi, cosa che accadde puntualmente in moltissimi Paesi europei, Italia compresa, per conseguenza della prima guerra mondiale[3]? Come si vede, la questione è molto più complessa di come tenda a presentarla il pensiero unico: perfino Lenin se n’era accorto, proclamando la guerra “levatrice della rivoluzione”. Altri, viceversa, si stupirono della paura della borghesia per la guerra, come Vilfredo Pareto, che pure era uno che possedeva un bel cervello: egli sostenne, in tempi non sospetti, che “…se c’è una grande guerra europea, il socialismo è ricacciato indietro almeno per un mezzo secolo. E la borghesia è salva per quel tempo.”[4] Pareri diversi, come si vede, perfino sullo stesso fronte: questo emerge, analizzando i fenomeni polemici dell’Età moderna. E, in particolare, proprio la Grande Guerra rappresentò un punto di rottura del pensiero politico e sociale di matrice ottocentesca: da una parte, essa fu la morte del Positivismo, che aveva dominato la seconda parte del XIX secolo e, dall’altra, fu la realizzazione delle aspirazioni di una massa proteiforme di persone, che soffocavano nella palude dell’Europa liberale e monarchica. Fu la morte dell’umanità, ma fu anche la culla di un’umanità nuova: un’umanità nè peggiore nè migliore, ma, certamente, diversa. Così, parlando della Grande Guerra vista con gli occhi degli intellettuali e, segnatamente, dei poeti, non si può non notare l’estrema varietà dei giudizi e delle posizioni: anzi, proprio questa varietà ne fu l’elemento distintivo.
Prima del diluvio
Il brodo di coltura da cui
scaturì la Grande Guerra
funzionava già da decenni, quando le pistolettate di Gavrilo Prinzip
scatenarono il conflitto: scaramucce coloniali[5] e
revanscismo[6],
indebolimento degli imperi sovranazionali e potenziamento dell’industria,
avevano già segnato il cammino verso la catastrofe.
Eppure, in Europa, ben pochi avrebbero creduto nel suicidio
di una civiltà: questo è il dato che balza per primo agli occhi. Va detto anche che, per l’Italia, una guerra
europea avrebbe avuto ben altro significato, rispetto a tutte le altre potenze
continentali: fin dalla guerra di Crimea (1855-56), i Savoia avevano
interpretato le guerre internazionali come un’occasione per loro di
incrementare il proprio dominio sulla Penisola[7]. La guerra austro-prussiana (1866) aveva permesso
di aggiungere al neonato Regno d’Italia la Venezia Euganea,
nonostante gli imbarazzanti disastri di Custoza e Lissa, così come quella
franco-prussiana del 1870 aveva distolto i Francesi dalla loro caparbia difesa
del Santo Padre, permettendo ai soldati di Raffaele Cadorna di entrare a Roma
da Porta Pia. Va da sè che, alla
vigilia di una nuova
guerra, inevitabilmente, negli ambienti vicini alla Corte, si sentisse odore di
acquisizioni territoriali. Quando
venne il momento per l’Italia di decidere se partecipare o meno al conflitto,
la guerra non era un’eventualità astratta: era già scoppiata. In questo contesto bisogna giudicare l’assoluta
specificità dei fenomeni, tutti italiani, dell’Interventismo e del Neutralismo,
che animarono la pubblicistica dei mesi che precedettero il 24 maggio 1915. Bisogna, del pari, tener conto che, per molti
Italiani, quella guerra non era la prima guerra mondiale, ma la quarta guerra
d’indipendenza. Di qui discendono i
giudizi, diversissimi tra loro, circa la necessità o meno di una nostra entrata
in guerra. D’altronde, se c’era chi
vedeva nella guerra l’ostetrica della rivoluzione, come i sindacalisti
rivoluzionari di discendenza soreliana, vi era anche chi, come, ad esempio,
Enrico Corradini, direttore del giornale nazionalista Il Regno,
giudicava il conflitto un’arma straordinaria per arginare proprio il socialismo
e garantire un ritorno all’ordine pubblico, oltre che una manifestazione della
“coscienza guerresca da opporre alla coscienza pacifista”[8]. A ciò si aggiungano le sirene formidabili,
rappresentate da Trento e Trieste, irredente e viste quasi in un alone
mistico-mitologico da molti intellettuali, per capire che il quadro, alla
vigilia del “maggio radioso” era tutt’altro che monocromo.
Già nel 1909, il creatore del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, proclamava
Trieste: “Faccia purpurea e violenta dell’Italia, rivolta verso il nemico (…) nostra unica polveriera!”, scagliandosi contro
tutti coloro che riteneva essere d’ostacolo al naturale espandersi delle razze:
passatisti, avveniristi e internazionalisti.
Il violentissimo e bellicoso linguaggio antiaustriaco di Marinetti lasciò il
segno, e fu il modello, insieme a quello di Gabriele D’Annunzio, della
pubblicistica interventista. Questo
richiamo alla guerra come turbine ed accelerazione della storia, contrapposto
alla staticità di una società liberale, inchiodata ai propri principi, dettati,
in sostanza, dalla vigliaccheria, animò il pensiero di molti pensatori di
quegli anni, e fiorì in gran parte sulle pagine di quelle riviste nuove, di cui
dicemmo nel paragrafo dedicato alla mobilitazione totale permanente, come La
Voce, di Prezzolini, su cui un filosofo del calibro di Giovanni Amendola
ebbe a scrivere: “Ma gli uomini, nonostante sappiano che dalla guerra non
avranno vantaggi materiali, continuano a prepararsi alla guerra, e c’è da
prevedere, senza esser profeti, che si combatteranno per l’avvenire, come si
son combattuti per il passato. Ciò
vuol dire che gli uomini preferiscono i mali della lotta, e il rischio, e il
dolore, ed anche la morte, a quello stato di pace in cui tutta la vita fosse
dominata da motivi economici e regolata saggiamente in base al tornaconto…”[9]. Come si può vedere, era largamente diffuso, negli
anni che precedettero la guerra, un sentimento di ribellione per quelle regole
di vita che il Positivismo aveva introdotto, e che venivano considerate come
espressione di materialità e, infine, di panciafichismo. Non a caso, allo scoppio delle ostilità, Amendola
avrebbe lasciato l’università di Pisa, per partire volontario, insieme a
moltissimi altri intellettuali come lui.
D’altra parte, era ben chiaro a molti il fatto che questa guerra non sarebbe
stata come tutte le altre: che avrebbe rappresentato una cesura netta tra il
vecchio mondo nato dal congresso di Vienna e un mondo nuovo, misterioso e
terribile, ma anche straordinariamente affascinante.
E non parteciparvi avrebbe significato perdere una grande occasione per
plasmare il futuro
dell’umanità. Giuseppe Prezzolini,
scrisse su La Voce del 26 agosto 1914 (si noti la data) parole
fondamentali per comprendere questo punto: “Il mistero della generazione di un
nuovo mondo europeo si compie (…) ed il
parto avviene tra rivi mostruosi di sangue e gemiti che fanno fremere. (…) Ci
darà la guerra quello che molti delle nostre generazioni hanno atteso da una
rivoluzione?”. Eppure, nelle stesse
pagine, proprio Prezzolini postula l’esistenza di un’ulteriore possibile
vigliaccheria: l’entrata in guerra per comodità, in linea con quanto abbiamo
scritto poco sopra, a proposito della tendenza sabauda ad approfittare delle
contingenze per fare il proprio interesse.
Questo rispecchia perfettamente un certo atteggiamento incline al
mercanteggiare, che caratterizzò l’attività diplomatica italiana di quei mesi,
tra Intesa ed Alleanza, in una sorta di asta sulla nostra entrata in guerra con
uno dei due schieramenti. Ebbene,
Prezzolini rifiuta le ragioni della convenienza: “Andiamo con l’idea che è
dovere andare, non con l’idea che mette conto andare. Siamo guerrieri e non mercanti…”.
Quindi, anche all’interno dello schieramento interventista, sono necessari
numerosi distinguo: da un lato potremmo collocare le ragioni della mente e
dello stomaco, che vedevano nella guerra la possibilità concreta di ottenere
(anche solo restando neutrali) consistenti cessioni territoriali dall’Austria-Ungheria. Dall’altro, però, vi era una fortissima tensione
eroica, che nasceva da una generazione allevata nel culto degli ideali
risorgimentali, ma che non aveva mai avuto l’occasione di mettersi alla prova. Per costoro, la Grande Guerra divenne
un palcoscenico formidabile: un’incudine su cui temprarsi o bruciare. In altro lavoro, parlando di D’Annunzio, indicammo
le parole d’entusiasmo con cui salutò lo scoppio delle ostilità: come una
liberazione. L’occasione era venuta. Finalmente, la guerra![10]
Proprio così salutò il conflitto immane Giovanni Papini, in una pagina de Lacerba,
dell’autunno 1914: “Finalmente è arrivato il giorno dell’ira dopo i lunghi
crepuscoli della paura. (…) E’ finita la siesta della vigliaccheria, della
diplomazia, dell’ipocrisia e della pacioseria.”. Erano dunque completamente impazziti, tutti questi
scrittori, che inneggiarono entusiasticamente al massacro e alla battaglia? In
un certo senso, sarebbe meno inquietante per noi pensare ad una sorta di follia
collettiva: e leggendo certe espressioni di Papini, come quelle sui vantaggi
per l’agricoltura derivanti dalla concimazione coi cadaveri dei campi, verrebbe
da pensarlo. Eppure, a parte i
paradossi e le provocazioni papiniani, dobbiamo ammettere che vi fu, nell’amore
per la guerra dei cantori dell’intervento, soprattutto una reazione feroce e, a
volte, scomposta, ad una vita senza eroismo.
Crediamo che la sciagurata frase di Bertolt Brecht sul bisogno di eroi sia una
delle peggiori idiozie che mai letterato abbia concepito (e Dio sa se ne hanno
concepite!). Una Nazione non può
vivere a lungo senza eroi: ne ha bisogno per riconoscersi e per sentirsi viva. E gli eroi più sacri e più disinteressati non possono che essere i
martiri guerrieri: altrimenti, si cerca di fabbricarsene di deteriori, e si
arriva a definire eroe un calciatore o un fotomodello. Certo, la guerra è cosa terribile e piena di
sofferenze: ma l’uomo, paradossalmente, ne ha bisogno, per ritrovare i propri
valori, la propria essenzialità, addirittura per apprezzare la pace.
Non è che anche chi scrive sia stato aggredito da questo
virus guerrafondaio: eppure, ai tempi belli della giovinezza, egli pure
constatò quanto possa lo spirito sulla mente.
Egli provò su di sè e vide sui coscritti il fascino magnetico dell’alzabandiera
e la purità del sentimento della Patria.
E ne conserva abbastanza buona memoria da garantire al lettore che gli
interventisti arrabbiati non eran pazzi.
Semmai erano invasati: ed è cosa affatto diversa.
Nessuno si sognerebbe di dire che Leonida fosse matto come un cavallo: perchè
lo si dovrebbe pensare di Marinetti o di Prezzolini? A questo si aggiungano le
spiegazioni razionali, di cui lo scrivente difetta, essendo egli eminentemente
uomo di trippe, ma di cui lo può benissimo sovvenire il filosofo Giovanni
Gentile, neoidealista e, naturalmente, favorevole alla guerra, che, in una
conferenza palermitana dell’ottobre 1914, così si espresse a proposito della
guerra come atto assoluto: “La guerra non è il conflitto di un certo
numero di Stati. Questo è bensì un
carattere necessario, ma uno solo dei caratteri di essa; e non è nè anche
l’urto di due tendenze o forze della politica mondiale (…) Non è
adunque, soltanto, una crisi economica, giuridica e politica (…) Si tratta, si badi, come sempre, di uno sforzo in
cui tutto, il Tutto, è impegnato: di un atto assoluto.
(…) Il nostro supremo e in questo senso il nostro
unico interesse.”. Gentile non si limitò a descrivere l’essenza della
guerra, ma affrontò, nella medesima circostanza, il problema cardinale per un
intellettuale di quegli anni: “E dobbiamo noi, uomini di pensiero e di studio,
gridare guerra o pace ai popoli, supposto che questi possano ascoltare la
nostra voce?”. La prima cosa che il
filosofo disse essere il dovere di un pensatore è “tacere”: porsi umilmente di
fronte alla grandezza degli avvenimenti e non unire la propria voce al coro
schiamazzante dei soloni da quattro soldi, sempre pronti a spiegare quale sia
il bene della Patria, sia che si tratti di guerre che di partite di calcio. La seconda è accettare la necessità ineluttabile
della guerra e guardare al nemico senza odio, come ad un fratello che condivida
con noi il compimento di un dovere supremo, cui tutti, intellettuali in testa,
devono concorrere. E gli
intellettuali concorsero ampiamente, facendo, anzi, a gara per chi raggiungesse
il fronte per primo. Ma non
precorriamo troppo i tempi: ci troviamo ancora nella fase di gestazione della
guerra. Abbiamo detto dei fautori,
talvolta forsennati, dell’intervento: essi ebbero voce potente, ma
rappresentavano, tuttavia, una netta minoranza di fronte al Paese. E’vero che tale rapporto di forze, se si esamina
soltanto la categoria dei letterati, variava sensibilmente a favore del
bellicismo; tuttavia non dobbiamo dimenticare che molti intellettuali di allora
si mostrarono tiepidi o addirittura decisamente ostili nei riguardi
dell’intervento italiano nelle ostilità già in corso.
In testa a tutti, naturalmente, quelli che oggi definiremmo gli uomini della
sinistra, socialisti in testa, che bollarono il conflitto come strumento
d’oppressione delle borghesie europee e non esitarono a scrivere “Abbasso la
guerra!” nei loro quattro manifesti contro la guerra[11]. Accanto ai socialisti, si dicevano nemici della
guerra anche i liberali di sinistra, i radicali, gli anarchici e buona parte
dei cattolici. Proprio in seno al
blocco socialista, però, cominciarono a distinguersi posizioni diverse sulla
questione dell’intervento: da una parte, Leonida Bissolati ed i suoi e,
dall’altra, i massimalisti rivoluzionari, cominciarono a parlare una lingua
diversa. Le loro ragioni erano,
sostanzialmente, opposte: i primi credevano che, nell’eventualità di una
guerra, gli Italiani avrebbero comunque dovuto compiere il proprio dovere[12],
mentre i secondi abbracciavano la teoria della strage levatrice della
rivoluzione. Vicino alle posizioni
del socialismo moderato e del liberalismo meno conservatore fu, ad esempio, il
grande filosofo Benedetto Croce, che, alla fine del 1914, scriveva su Italia
nostra: “La guerra è come l’amore e lo sdegno: qualcosa che mille raziocini
ed incitamenti non producono, ma che, a un tratto, non si sa come, si produce
da sè, invade l’anima e il corpo, ne centuplica e indirizza le forze, e si
giustifica da sè, per il solo fatto che è ed agisce.
Auguro al mio Paese di far la guerra solo quando sarà entrato spontaneamente in
questa crisi di amore e di furore, che è arra di vittoria o, almeno, di lotta
gloriosa.” .
Sono parole diverse da quelle che ci si sarebbe aspettati da Croce, a
dimostrazione del fatto che, nelle contingenze della storia, l’opinione di
ognuno va presa per quello che è in quel momento, a prescindere dalle sue
scelte anteriori o successive.
Sull’altro versante, ossia su quello massimalista, tempestava, con ben altra
prosa, Benito Mussolini, che, da direttore del quotidiano socialista Avanti!,
nell’ottobre del 1914, fece propria la dottrina della “neutralità attiva ed
operante”, che l’avrebbe portato, di lì a poco, all’espulsione dal partito e
alla decisa deriva interventista.
Fondato un nuovo giornale, Il Popolo d’Italia, Mussolini iniziò una
formidabile campagna a favore dell’intervento, giustificandola paventando una
vittoria dei “barbari” tedeschi, che sarebbe stata fatale per l’Europa, sia
borghese che proletaria. Così,
questo Mussolini prefascista, si rivolgeva alla gioventù italiana, esortandola
a combattere a fianco dell’Intesa: “(…) E’ a
voi, giovani d’Italia; giovani delle officine e degli atenei; giovani d’anni e
giovani di spirito; giovani che appartenete alla generazione cui il destino ha
commesso di <<fare>> la storia; è a voi che io lancio il mio grido
augurale, sicuro che avrà nelle vostre file una vasta risonanza di echi e di
simpatie. Il grido è una parola che
io non avrei mai pronunciato in tempi normali, e che innalzo invece forte, a
voce spiegata, senza infingimenti, con sicura fede, oggi: una parola paurosa e
fascinatrice: guerra!”. Come
si vede, la metamorfosi da socialista a fascista era già iniziata nel futuro
Duce; e proprio lui ci dice che fu la guerra ad originare questa metamorfosi. Come nel caso di Mussolini, così in quello di
milioni di altri giovani italiani, la Grande Guerra avrebbe rappresentato il punto di
non ritorno, oltre il quale non si poteva più accettare il mondo borghese e
pacifico del liberalismo dell’Italietta.
Nel bene e nel male, il futuro
sarebbe stato dell’Italia, senza diminutivi.
Una cosa notevole di quei giorni è anche la nascita di una nuova retorica: di un
nuovo stile letterario ed esistenziale insieme.
Principale interprete di questa tendenza fu, naturalmente, Gabriele D’Annunzio:
suo epigono, rozzo ma efficace, fu lo stesso Mussolini.
Si confronti, ad esempio, il celebre periodo dannunziano dell’arringa al popolo
romano del 13 maggio 1915 (“Se considerato è come crimine l’incitare alla
violenza i cittadini, io mi vanterò di questo crimine, io lo prenderò sopra me
solo.”) con quello altrettanto
celebre che Mussolini indirizzò al parlamento a proposito delle violenze
squadriste (“ se il fascismo è un’associazione per delinquere, io sono il capo
di questa associazione per delinquere…”):
l’analogia potrebbe apparire stupefacente, se non si conoscesse l’enorme debito
che la retorica del Ventennio contrasse nei riguardi di D’Annunzio, in
particolare, e della cultura interventista più in generale. In realtà, bisogna tener conto del fatto che,
proprio durante la guerra e a causa della guerra, si formò quell’enorme carica
d’energia politica e sociale che portò all’ascesa del fascismo: è del tutto
normale, dunque, che la maggior parte degli intellettuali fascisti si fosse
formata su quel tipo di retorica e di visione della vita, esattamente come le
generazioni precedenti si erano abbeverate di Risorgimento. Stava nascendo, nell’Italia del 1914-15, una nuova epopea, che avrebbe
dato vita ad una nuova
epica: terminava l’età dell’intervento e cominciava quella della guerra vera e
propria.
[1] Girotondi, manifestazioni, bandiere e stendardi alle finestre, scioperi sessuali (Lisistrata) e sindacali
[2] Alla formazione dell’esercito, in quasi tutte le civiltà antiche, si concorreva in base alla propria nascita o alla propria ricchezza: sia nell’oligarchica Sparta che nella democratica Atene la plebe urbana e contadina non partecipava alle battaglie
[3] Crediamo bastino, come esempi contrapposti, la rivoluzione sovietica e quella fascista
[4] In un articolo su Il Regno del 21 febbraio 1904
[5] Gli incidenti di Fascioda (la cosiddetta “guerra di Fascioda” 1898-1906) tra Gran Bretagna e Francia e di Agadir (1911) tra Francia e Germania
[6] Si chiamò così lo spirito di rivincita (“revanche”) radicatissimo in Francia dopo la sconfitta del 1870 e la perdita di Alsazia e Lorena)
[7] Dopo gli accordi segreti di Plombières (1858), Napoleone III affiancò il Piemonte nella seconda guerra d’indipendenza
[8] Parole pronunciate in un discorso a Savona, nel dicembre 1913
[9] 2 marzo 1911, nella recensione del libro di N. Angell The great illusion
[10] Je ne suis plus en terre d’exil,/je ne suis plus l’étranger à la face blême,/je ne suis plus le banni sans arme ni laurier.
[11] Si tratta dei manifesti elaborati dalla Direzione socialista il 29 luglio, il 22 settembre ed il 20 ottobre 1914, nonchè di quello pubblicato la vigilia della nostra entrata in guerra, il 23 maggio 1915
[12] Questo atteggiamento fu comune a molti giovani intellettuali, non interventisti, ma neppure sabotatori, che accettarono di compiere il proprio dovere fino in fondo, “in ossequio alle sacre leggi della Patria”: tra loro, esemplare fu il caso di Renato Serra, che ne scrisse in modo limpidissimo nella sua riflessione intitolata Esame di coscienza di un letterato, pubblicata su La Voce il 30 aprile 1915 e che sarebbe caduto il 20 luglio successivo sul Podgora.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.