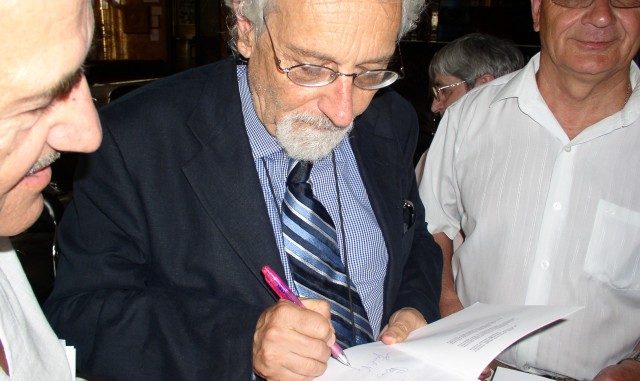
Nel 1830 e nel 1870, due correnti migratorie italiane provenienti soprattutto da Bisceglie, Trani e Molfetta giunsero in Crimea, in particolare nella regione costiera di Kerc, città posta sull’omonimo stretto che congiunge il Mar Nero col Mar d’Azov. Erano marinai, pescatori e agricoltori e alla navigazione nel Mar Nero e alle coltivazioni si dedicarono raggiungendo, in breve, un ragguardevole benessere. Negli anni successivi, parenti e amici si aggiunsero e si sparsero per la Crimea, raggiungendo le circa 5.000 unità.

Un ragazzino della comunità italiana di Crimea assieme ad ufficiali zaristi.
L’avvento del comunismo peggiorò la situazione. Negli anni Trenta, le “purghe staliniane” colpirono anche gli Italiani di Crimea. Molti di essi vennero arrestati con l’accusa di filo-fascismo e di spionaggio e sparirono nel nulla. La collettivizzazione delle terre obbligò gli agricoltori a riunirsi in kolchoz (proprietà agricola collettiva), e le loro terre furono espropriate (molti italiani furono raggruppati nel kolchoz “Sacco e Vanzetti”). Temendo il peggio, alcuni decisero di fuggire in Italia, perdendo tutto. Dopo il 1939, tuttavia, Mosca impedì agli italiani di abbandonare la Crimea, pena la deportazione. Circa 3.000 Italiani restano così intrappolati nella penisola. Quelli che riuscirono a scappare, lo fecero a bordo di fragili barche da pesca, affrontando viaggi avventurosi e terribili che nessuno fino ad oggi ha mai raccontato. Per ordine di Stalin, a Kerc vennero inviati rifugiati italiani comunisti con il compito di rieducare ‘ideologicamente’ gli italiani. Paolo Robotti, cognato di Togliatti, e Giuliano Paietta, fratello del più noto Giancarlo, iniziarono ad indottrinare al marxismo gli italiani e, nel contempo, fecero chiudere la chiesa e la scuola costruite dai nostri connazionali. Nel settembre 1941, le forze armate della Wehrmacht occupano la Crimea, ma ai primi del 1944 ecco di ritorno l’Armata rossa. Gli italiani furono accusati di collaborazionismo e tradimento, e di conseguenza scattò l’ordine di deportazione, che avvenne in tre fasi: il 28 e 29 gennaio, l’8 e 9 febbraio, e 24 giugno, mese in cui vennero deportate in Siberia e nella Russia asiatica anche tutte le altre minoranze nazionali della Crimea. Vennero deportate anche le famiglie miste, bastava un componente di origine italiana. Furono deportati tutti, dai neonati ai vecchi, e toccò a questi morire nell’atroce viaggio che li portò attraversò ben sette repubbliche sovietiche (Ucraina, Russia, Georgia, Azerbaigian, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan. La vita a bordo delle tradotte era, infatti, spaventosa: Chiusi in vagoni bestiame piombati, i deportati italiani patirono la fame, la sete, il gelo e le malattie. La ricostruzione di quell’inferno, avvenuta grazie ad alcune interviste ai testimoni, è tragica. Prima di essere trasferiti ai convogli, ad ogni famiglia furono concessi pochi minuti per ammucchiare qualche capo di vestiario e qualche ricordo in un sacco che non doveva superare gli otto chili. Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 1944, i membri della comunità italiana furono rastrellati casa per casa e trasportati a Kamysh-burun, un sobborgo di Kerc. All’alba del giorno dopo, gli Italiani furono stipati nelle stive e traversarono lo stretto di Kerc, quindi nei vagoni fino a Bakù e da lì, rinchiusi in altre stive di navi merci, traversarono il Caspio in direzione est. Raggiunta la costa, i deportati furono rinchiusi e trasferiti in convogli ferroviari fino a Atbasar e Akmolinsk: viaggio che durò 36 giorni. Nelle memorie di Bartolomeo Evangelista il vitto viene descritto come “una magra sbobba ci veniva data qualche volta alle stazioni dove si fermava il convoglio, se il capotreno riusciva ad organizzarne la distribuzione, altrimenti non mangiavamo”. Sempre Evangelista racconta che della sua famiglia composta da 11 persone ne sopravvissero soltanto cinque, mentre delle famiglie Simone e De Martino sopravvissero due persone su sette e cinque. Dei bambini non ne rimase in vita alcuno. La testimonianza di Speranza Giacchetti Denissova descrive in maniera cruda i tanti che morirono durante il viaggio: “Nei primi giorni fummo così stretti che non fu possibile sdraiarsi; era difficile anche muoversi e respirare. Poi lo spazio iniziò ad aumentare poiché le guardie sovietiche iniziarono a scaricare i cadaveri dei nostri compagni. I superstiti infine furono portati a Karagandà, la famosa ‘città-gulag’, dove vennero, tra l’altro, imprigionati migliaia di soldati italiani dell’ARMIR (Armata Italiana in Russia). Nella testimonianza di Emilia Petrinca, raccolta da Larissa Giacchetti, viene descritta la situazione: “Il pavimento delle baracche era di terra, ed eravamo costretti a dormire tutti insieme. Non esistevano servizi igienici. E spesso le guardie non ci davano nemmeno da mangiare”. Nadia Simone, nipote di Marco Simone, emigrato in Crimea nel 1899 e diventato attivista comunista e responsabile del kolchoz “Sacco e Vanzetti” racconta le testimonianze indirette raccolte dai suoi compagni di prigionia: “Mancanza di cibo, freddo, congelamenti, pestaggi e umiliazioni”.

Una famiglia di italiani della Crimea deportati dai sovietici in Asia Centrale.
Una famiglia decise di lasciarsi morire, fortunatamente trovò sotto la neve i resti di un cavallo morto, e con questi sopravvisse. “Con l’arrivo del disgelo, i bambini mangiavano i bulbi di tulipano della steppa”. Angelina Cassinelli ricorda che il responsabile del kolchoz a cui era stata assegnata, urlava: “Volete pane? Chiedetelo a Mussolini”. Oppure: “Ricordatevi. Siete stati portati qui perché moriate tutti”. Dopo il decesso di Stalin, gli internati italiani sopravissuti poterono fare ritorno in Crimea: erano rimasti appena in 300, cioè il 10% dei deportati. Alcuni rimasero in Kazakistan o addirittura si trasferirono in Uzbekistan dove ancora si trovano i loro discendenti. Infatti, a Kerc e nel resto della Crimea tutti i beni immobili e le terre degli italiani erano stati confiscati dallo Stato marxista. Con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, le speranze della Comunità italiana di Crimea si riaccesero, ma la Repubblica italiana preferì ignorare la tragedia da loro vissuta, abbandonandoli al loro destino, e respingendo al mittente ogni richiesta di aiuto. Rammentiamo che tutte le altre minoranze etnico-linguistiche della Crimea riuscirono ad ottenere qualche attenzione da parte dei loro Paesi di origine. I tatari, i tedeschi, i greci, i bulgari, gli armeni ottennero il riconoscimento di ‘minoranze deportate’ e molti furono rimpatriati ed in seguito reinseriti nella società. Così non accadde per gli italiani. Roma giustificò il suo menefreghismo appellandosi al fatto che essi non possedevano più il passaporto, ma tacendo sul fatto che tutti i loro documenti erano stati sequestrati al momento della deportazione. Chi scrive consegnò di persona al nostro ambasciatore, Irene Brunetti, le copie a carta carbone delle suppliche fatte da ex deportati, ma non ricevetti mai una risposta. L’unico ad interessarsi della questione fu l’ex premier Silvio Berlusconi che riuscì ad organizzare un incontro tra gli ex deportati Giulia Giacchetti Boiko e Anatolij De Martino e Putin, a Yalta. E si deve allo stesso premier Putin il riconoscimento ufficiale russo (e il conseguente trattamento di favore) di ‘popolo deportato’ agli Italiani di Crimea.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.